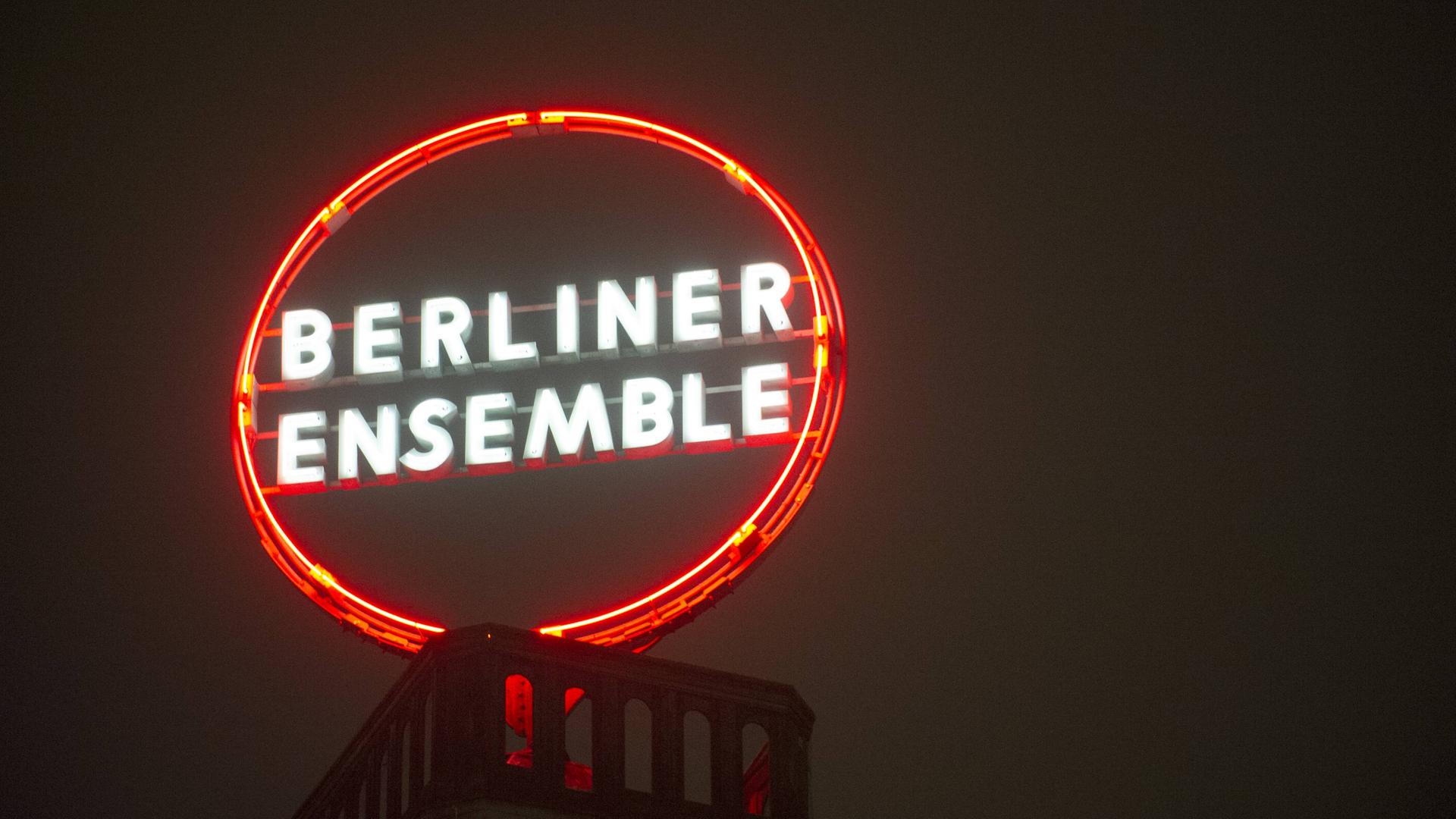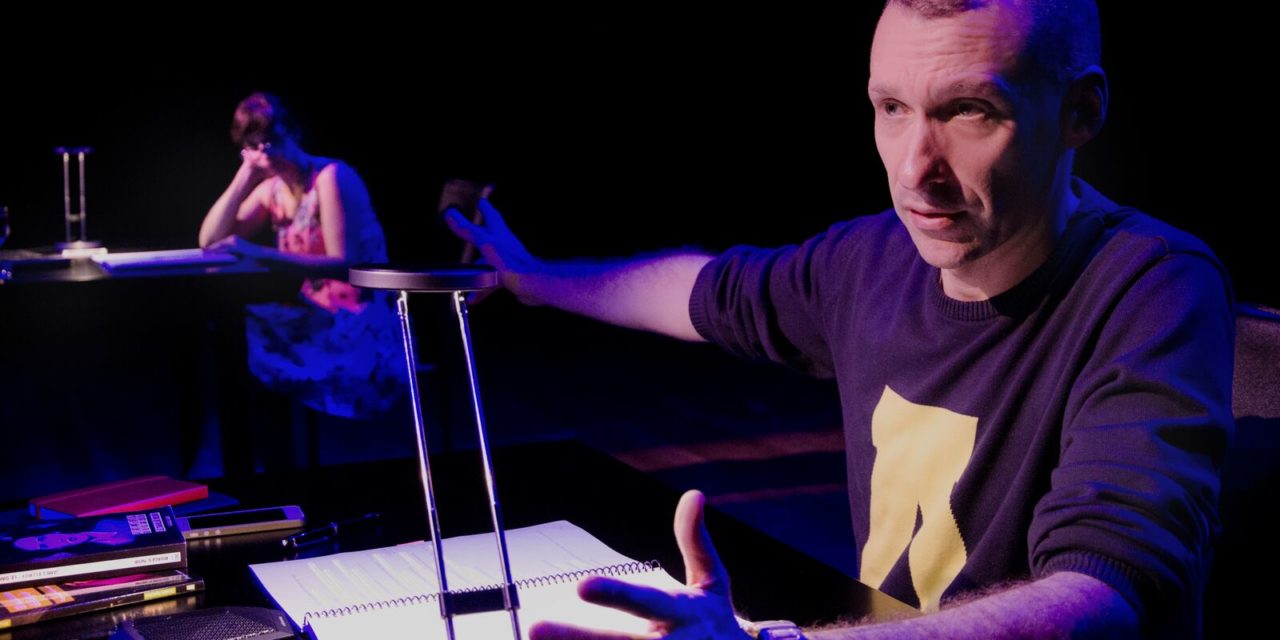Franco Perrelli, professore ordinario, ha insegnato Discipline dello Spettacolo nelle Università di Torino e di Bari. Ha vinto il Premio Pirandello 2009 per la saggistica teatrale ed è stato insignito dello Strindbergspris della Società Strindberg di Stoccolma nel 2014. Fra le sue recenti pubblicazioni si segnalano: Le origini del teatro moderno (2016), Poetiche e teorie del teatro (2018), On Ibsen and Strindberg. The Reversed Telescope (2019), Kaj Munk e i suoi doppi (2020). Ha inoltre curato il volume delle Lettere di Strindberg per Cue Press. Negli ultimi tre anni, Perrelli ha tradotto e curato le edizioni italiane dei romanzi della Trilogia della solitudine di Strindberg, tutti e tre pubblicati dall’editore Carbonio: Solo, La festa del coronamento e Il capro espiatorio, che rimase l’ultimo romanzo di Strindberg.
Come è nato il suo interesse per August Strindberg? Adesso, dopo i suoi lunghi studi sul drammaturgo svedese, quale pensa che sia il ruolo che Strindberg ha giocato nell’evoluzione del teatro e della letteratura occidentale tra Ottocento e Novecento?
L’interesse è nato quand’ero studente. Mi capitò fra le mani, casualmente, in una libreria una vecchia traduzione del dramma Un sogno e restai affascinato dalla forma e dalla filosofia, insieme pessimista, ma quotidiana, straordinariamente umana, immediata. Uno Schopenhauer alla portata dell’esperienza di ognuno, potrei dire; il dolore che si stende sul mondo («Che pena gli uomini!»), l’inevitabilità del male, il mistero di questo squilibrato assetto del mondo, la domanda posta a un Dio insondabile. In seguito, in un’altra libreria, a Edimburgo, dove stavo studiando inglese, m’imbattei in una versione del suo ultimo dramma, il suo testamento spirituale, La grande strada maestra. Rimasi folgorato dall’intensità del monologo finale. Non era tradotto in italiano e decisi di studiare lo svedese e farlo io. Ero già laureato, ma – oltre a studiare privatamente – potei seguire i corsi di un grande germanista, e anche scandinavista, Aloisio Rendi. In seguito, sarei andato ad approfondire la lingua svedese a Lund e a Stoccolma, dove fui subito aiutato dalla Società Strindberg. Insomma, nel 1980 uscì il mio primo Strindberg per i tipi del Formichiere, una casa editrice aperta alle novità, diretta da Stefano Jacini, che era molto interessato a questo autore. Gli anni Ottanta furono del resto, in Italia, anni di un’intensa e straordinaria riscoperta, in editoria e sulle scene, di Strindberg, che si capiva essere chiave nella cultura moderna, ma più che mai attraente in un periodo in cui, dopo il Sessantotto, ci si confrontava ancora con le avanguardie, si aveva il gusto del rinnovamento dei repertori e della riscoperta, anche dell’utopia. Noterò incidentalmente che, non a caso, lo Strindberg di quegli anni è spesso più colorato di socialismo di quanto non fosse opportuno. Comunque la centralità di Strindberg nella cultura occidentale, in assoluto e in poche parole, tra gli altri, l’hanno certificata Kafka («Non lo leggo per leggerlo, ma per stringermi al suo petto») e O’Neill (è «il più moderno dei moderni»).
Da dove nasce la definizione di «Trilogia della solitudine»?
Potrei cavarmela asserendo: nei fatti, vale a dire nei testi. Strindberg lavora in questi romanzi direttamente sul tema della solitudine, che però percorre in fondo gran parte della sua opera: «Sono solo, naufrago, un relitto, gettato su uno scoglio nell’oceano, ci sono attimi in cui mi afferra la vertigine di fronte all’azzurro nulla» (August Strindberg, Leggende).
La definizione di «trilogia della solitudine», in verità, mi è apparsa quasi palpabile durante il periodo dell’isolamento del Covid, quando la maggior parte del lavoro è stato portato avanti. Ognuno, nella propria solitudine, sentiva di dover alleviare in qualche modo quella degli altri. E quale contributo migliore se non offrire opere dove il tema viene approfondito e illuminato comunque da una luce di coraggio? Le edizioni Carbonio – raffinatissime e sensibilissime – hanno subito accompagnato la mia idea di ripubblicare tre romanzi che, a suo tempo, avevo tradotto per un editore che non esiste più. All’epoca, peraltro, i testi avevano subito delle trasformazioni redazionali (sin dal titolo); nel frattempo in Svezia era uscita l’edizione critica, c’erano modifiche da apportare e sempre qualcosa da correggere e migliorare alla luce dell’esperienza. Insomma, un’ottima occasione per un rifacimento consapevole.
Secondo lei, a cosa si deve il fatto che, pur appartenendo alla fase di piena maturità del suo percorso autoriale, questi tre, ultimi romanzi di Strindberg sono meno noti di altri drammi dello stesso periodo?
È un problema che risale addirittura all’epoca di pubblicazione, soprattutto dei due ultimi romanzi del 1906: la critica non li notò particolarmente. Diversi decenni dopo, in pieno Novecento, sono stati reputati quanto di meglio abbia scritto Strindberg e, in assoluto, fra la prosa più notevole della letteratura nordica. Credo che, ai suoi tempi, da Strindberg ci si aspettasse sempre un approccio polemico alla realtà, alla vita, massime nei confronti del sesso e delle donne, ma anche in campo religioso. Solo, La festa del coronamento e Il capro espiatorio hanno un tono più morbido, una considerazione particolarmente sensibile dell’esistenza, un bisogno di consolare e autoconsolarsi. Certo, in filigrana, affiorano il pessimismo e lo gnosticismo strindberghiano, ma bilanciati da una sorta di coraggio di vivere, di fluttuante speranza, di attesa di un esito inusitato e di una qualche risposta al dolore umano.
Nella sua prefazione a Il capro espiatorio lei accenna all’influenza della «formula del romanzo di Balzac», sia pure filtrata in una chiave personale, in un tentativo di «creare una comèdie humaine svedese». L’attenzione al «metodo di Balzac» venne rivendicata dallo stesso Strindberg nel suo epistolario. Quali erano gli altri antecedenti dello Strindberg romanziere?
Fin dal 1879, con la pubblicazione del grande romanzo d’esordio, La Sala rossa, Strindberg fu inteso come un autore sperimentale, «di rottura», e paragonato con quanto di estremo e anche scandaloso si concepisse al tempo, vale a dire: Zola. Credo tuttavia che, oltre a Balzac, soprattutto Dickens abbia lasciato una forte impronta su Strindberg, insieme a Goethe, Hugo e anche Dostoevskij. Nei due ultimi romanzi, poi, si avverte un’atmosfera riscontrabile nella narrativa romantica tedesca.
Al termine della sua prefazione a Il capro espiatorio lei scrive che l’immaginario di Strindberg è attraversato «da quella fine misura d’ironia che muta un cupo piagnisteo in un’onesta testimonianza sull’essere uomini», parole che in una certa misura si potrebbero applicare anche all’esistenzialismo letterario, movimento emerso tre decenni dopo la morte di Strindberg. Dal suo punto di vista, quali sono state le maggiori eredità di Strindberg sugli autori classici del romanzo novecentesco?
Strindberg non solo ha condizionato effettivamente l’esistenzialismo moderno, essendo stato a sua volta suggestionato da Kierkegaard, ma questo influsso è stato anche chiaramente riconosciuto da romanzieri-pensatori di questa corrente. Infatti, Albert Camus l’ha definito «il guardiano e il testimone della rivolta dell’individuo», che «ci aiuta a ricordare e a sostenere quella follia della creazione ch’è l’onore dell’essere umano». A Kafka ho già accennato.
A livello di prosa, quali sono state le maggiori difficoltà nel tradurre i tre romanzi di Strindberg? Il suo svedese quali specificità ha?
L’opera strindberghiana si segnala per una varietà di fasi e di registri, è immersa in atmosfere che spaziano dal romanticismo, al naturalismo, al simbolismo. Ma questi «-ismi», con Strindberg, vanno considerati in termini meramente convenzionali: Strindberg è Strindberg, e le faccio un esempio. Lo si considera storicamente, e in un certo senso giustamente, alle origini dell’espressionismo, ma il suo espressionismo è in fondo il misticismo barocco di Swedenborg, filtrato e rivissuto dalla sua ipersensibilità. Ciò premesso, la lingua di Strindberg presenta forti scompensi e scarti: da un livello decisamente poetico all’innesto di termini connessi alle scienze, alla tecnologia, alla chimica, che talora originano neologismi. Il traduttore, da un lato, deve centrare bene la fase biografica e storico-letteraria in cui l’opera cui si dedica va a collocarsi, ma, da un altro, essere poi pronto all’imprevisto e attento soprattutto al ritmo della frase. Strindberg, infatti, è uno scrittore eminentemente ritmico; più ritmico che logico. Anche ai suoi attori chiedeva soprattutto il senso del ritmo.
Strindberg si autodefiniva «uno scrittore religioso» e ha spesso costellato i suoi drammi e i suoi testi di citazioni e riferimenti biblici. Il capro espiatorio si rifà all’Antico Testamento sin dal titolo, e non sembra accennare a particolari possibilità di redenzione, a differenza di come l’incarnazione narrata dei Vangeli ha rimodulato il tradizionale archetipo dell’agnello sacrificale. Quali riferimenti biblici ha colto nell’ultimo romanzo di Strindberg, e come li ha resi in traduzione? Il passaggio da un orizzonte concettuale «protestante», incarnato nello svedese, a uno «cattolico», qual è quello italiano, ha comportato qualche complessità di traduzione?
La definizione di scrittore religioso deriva in Strindberg direttamente da Kierkegaard e si lega a un’idea severa del rapporto con Dio, rispetto al quale «si ha sempre torto», che rimanda a sua volta alle radici pietistiche dell’infanzia dell’autore svedese. Essere uno «scrittore religioso», per Strindberg, tuttavia, non significa mai essere un autore pio o edificante, bensì incarnare una figura d’indagatore antagonista che chiede a Dio ragione dell’inesplicabile della vita. Non solo nei romanzi della «trilogia della solitudine», ma in tutta l’opera strindberghiana i modelli eroici sono tratti dalle figure bibliche di Giacobbe che lotta con Dio e di Giobbe che interroga sul senso dell’esistenza e del dolore. Il sacrificio di Cristo resta un mistero affascinante e quasi inafferrabile: in fondo (e si legga proprio Il capro espiatorio), il suo esempio è metafora della condizione umana, la sua incarnazione per antonomasia è al livello di tutti gli esseri umani, come la sua offerta di redenzione – ma perché mai c’è stata e perché l’umanità non l’ha riconosciuta fino alla crocifissione e dopo? A tratti, in Strindberg, questo intenso dissidio metafisico ed esistenziale si muta almeno in una speranza di chiarimento nell’aldilà, occasionalmente, in una rassegnata sottomissione, non di rado nel dubbio gnostico sull’esistenza di un nume malvagio. Insomma: un quadro inquieto e fortemente contrastato; una religione come interrogazione vertiginosa e aperta, mai come pacificata pratica devota. Un grande regista nostro contemporaneo, il polacco Jerzy Grotowski, sosteneva che gli dèi in fondo amano proprio coloro che praticano nei loro confronti la blasfemia, perché sono gli uomini che del divino si ricordano con più insistenza e passione. Insomma, la religione è tutto meno che materia tiepida, e anche Strindberg ce lo ricorda. Il traduttore deve tenere presenti queste inquietudini e questi squilibri, immergersi nella dinamica interiore del conflitto che, in uno scrittore, si fa ovviamente lingua. Cattolici? Protestanti? È l’umanità che ha inventato la teologia, Dio si è dedicato e si dedica a tutt’altro. Anche questo c’insegna Strindberg: il divino resta misterioso, attingibile forse solo nell’abbandono di un salto acrobatico. Per questo, i personaggi strindberghiani risultano spesso clowneschi.
Tra le sue precedenti pubblicazioni legate a Strindberg c’è anche la curatela del suo epistolario edito da Cue Press. Tra gli scrittori dell’Ottocento, Strindberg è stato uno dei più espliciti e franchi nel parlare della propria vita interiore, anche nei suoi aspetti maggiormente morbosi e patologici. Le tre vicende raccontate nella «trilogia della solitudine» fino a che punto riflettono esperienze e sensazioni vissute personalmente e biograficamente dallo scrittore svedese?
Strindberg ha teorizzato esplicitamente che l’autobiografia è la prima materia di una letteratura che voglia andare a fondo del cuore umano e, proprio in un passo dell’epistolario (che è, tra l’altro, uno straordinario documento personale e storico), si paragona per questo a una «cavia». Ciò, sin dal principio, ha orientato la critica (penso alla prestigiosa monografia di Martin Lamm) verso una forte identificazione fra vita e opera. In gioventù, ero più vicino alle correnti critiche d’avanguardia che miravano a smontare questo approccio, che, in effetti, può essere riduttivo sul piano estetico per un’opera letteraria. Con gli anni, però, il diavolo si fa frate (mi pare fosse un motto di Hegel), e pur non schiacciandomi mai sulla mera equivalenza opera-vita, non trascuro di evidenziare il nesso autobiografico. Mi pare più corretto: se uno scrittore si costruisce così, perché smontargli del tutto il giocattolo? In ogni caso, è una costruzione che va descritta. Il lavoro di critico, di storico della letteratura, a ben vedere, è il più simile a quello dell’attore: bisogna entrare nella pelle dell’orso (come dicevano in gergo i comici di un tempo) per penetrare il più possibile in personaggi, epoche e atmosfere, spesso remotissime. Ci si riesce? Gli attori (anche se non tutti lo ammettono) sanno bene che la cosa è possibile solo fino a un certo punto, e nessun critico sosterebbe il contrario, ma lo sforzo d’immersione va fatto (ed è pure l’aspetto più affascinante e gratificante del mestiere), anche se non si riesce mai a perdere la propria contemporaneità. Con Strindberg, quindi, cerco di vestirmi con la sua pelle, di ragionare nelle sue categorie e in quelle del suo tempo. Poi so bene che l’arte – autobiografica o meno che sia – è strutture, simboli, idee e lingua, e soprattutto con questo, fuori dalla semplice aneddotica, debbo confrontarmi. Alla fine, cerco di adottare un metodo che potrei definire comprensivo e analitico-comparativo insieme. Vengo da studi filosofici e do molta importanza alle idee dell’autore e del suo tempo; credo che sia necessario (anzi ovvio) essere rigorosi, ma anche che scienza, per la critica, significhi ben altro rispetto a ciò che il termine può evocare in campi differenti e più consoni, e non mi fa orrore, col giusto distacco, l’invito crociano al giudizio personale. È un’ipocrisia della critica scientifica credere che non vada espresso o non lo si esprima mai.
In passato lei ha tradotto Strindberg anche direttamente per il teatro, per una messa in scena di Gabriele Lavia; più di recente è apparso, in un volume collettivo dell’Istituto degli Studi Germanici, il suo testo Appunti di un traduttore di teatro. Per la sua esperienza, quanto cambia il mestiere del traduttore dalla carta alla scena? E quando traduce per il teatro, in che misura instaura un dialogo, oltre che con il testo di partenza, anche con l’attore che fisicamente dovrà recitare le battute?
Ho una discreta esperienza di traduttore per il teatro (un ambiente, tra l’altro, che ho avuto modo di conoscere bene e che confesso di amare per la sua serietà e per le sue debolezze). Anche in questo caso, ammetto di avere avuto un’evoluzione: nelle mie prime versioni, in assoluto, cercavo di perseguire il più impervio degli ideali umani, la fedeltà. Che cosa sia in una traduzione potremmo discuterne per decenni, ma diciamo che, per me, significava una stretta aderenza di termini, ricorrenza di didascalie, al limite anche una certa rigidità formale. Oggi non rinnego nulla di tutto ciò, ma – proprio lavorando recentemente su Ibsen per un Meridiano Mondadori che sto curando – mi ha colpito il richiamo di questo drammaturgo all’assoluta necessità che un testo riviva in un’altra lingua nelle categorie e nella sensibilità per l’appunto della lingua nella quale viene riportato. Svedese, norvegese, danese (le lingue da cui di norma traduco io) sono diversissime strutturalmente dall’italiano, non sono di ascendenza latina, ma oggi tendo ad assecondare più le ragioni del mio idioma che la logica stringente di quello scandinavo. In questo caso, so che esistono biblioteche di filosofia della traduzione e ponderosi trattati scientifici nel merito; li ho pure letti. Poi però, nel lavoro, vince la vita, l’esperienza, il gusto della letteratura, e tradurre (come anche il lavoro critico) resta un’operazione di alto artigianato, con imponderabili margini soggettivi. Ho mai tradotto pensando agli attori? Non so: in genere, tendo a vivere il dialogo drammatico dentro di me. Di norma i registi e gli attori mi chiedono traduzioni «moderne»; io credo di assecondare, ma tanto so che in scena cambierà tutto o quasi. Il teatro sulla pagina e quello vissuto sono intraducibili a vicenda; a un certo punto, lo fa intendere persino Hegel nelle sue lezioni di estetica.
Dopo il completamento della «trilogia della solitudine», ci sono altri scritti di Strindberg inediti in italiano che spera di portare a traduzione?
Sì. Mi piacerebbe affrontare I libri blu, l’immenso zibaldone, dedicato a Swedenborg, della vecchiaia di Strindberg. E magari lasciare un’edizione aggiornata della sua drammaturgia più importante, come in questo momento sto facendo con Ibsen. Ahimè, è però noto il motto: «ars longa, vita brevis»… e, a una certa età, si sbircia più di frequente la clessidra sullo scrittorio.
Collegamenti