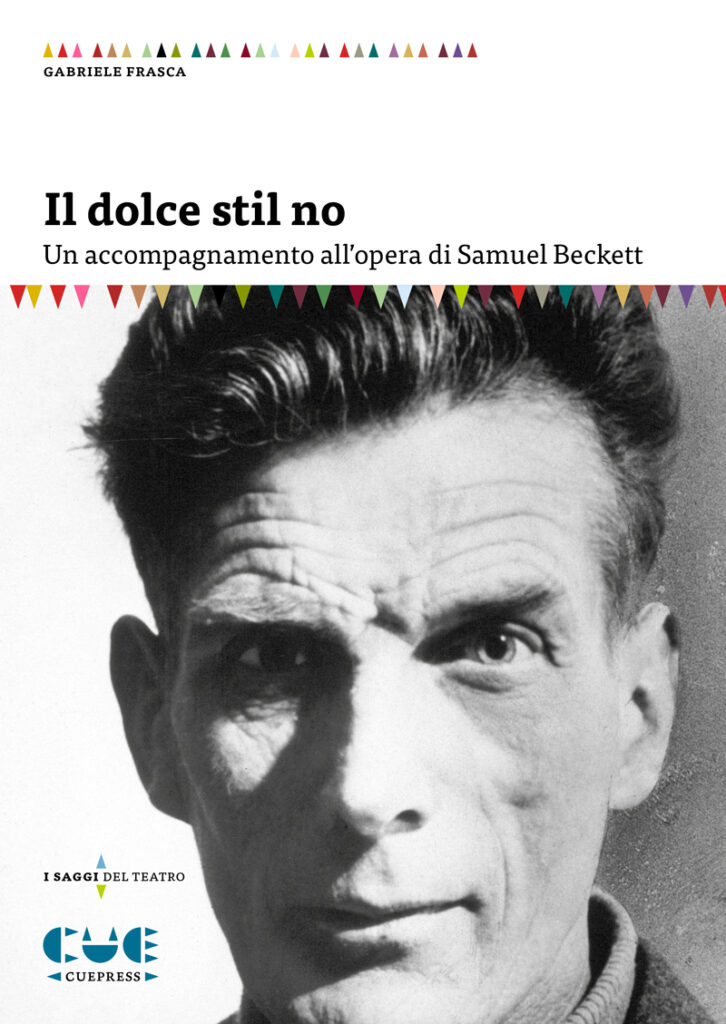Intervista a Gabriele Frasca
Matteo Marelli, «Film TV», XXXII-5
L’occasione di dedicarci a Samuel Beckett e di confrontarci con Gabriele Frasca, poeta, massimo studioso italiano, curatore e traduttore del recentissimo Meridiano dedicato all’autore (Beckett – Romanzi, teatro e televisione), ci è offerta dall’uscita in sala di Prima danza poi pensa – Alla ricerca di Beckett, fantasioso biopic di James Marsh. «Fantasioso» perché il film si apre su un episodio mai accaduto, ma capace d’inquadrare il tormentato rapporto che Beckett ebbe con il trionfo: lo vediamo all’Accademia reale svedese commentare la vittoria del Nobel con un lapidario «Che catastrofe!». Nella realtà, non andò a ritirare quel premio. Perché, cosa temeva della «condanna alla fama»?
Temeva la disattenzione dall’opera. Comunque a esclamare «Quelle catastrophe!» fu la moglie, Suzanne Dechevaux-Dumesnil. Poi, come dici, Beckett non ritirò il premio, cosa che fece Jérôme Lindon, il suo editore francese. Decise comunque di presentarsi a patto di non rispondere a nessuna domanda e d’intrattenersi per le foto di rito il tempo necessario a fumare un sigaro. La scena, che venne poi replicata a favore di un’emittente svedese, la si trova su YouTube. Beckett non era contro il Nobel, anche se, attenzione, fu veramente tentato di rifiutare, ma per un motivo ben diverso da quello prospettato dal biopic: a rivelarcelo è stato uno dei suoi attori preferiti, nonché suo grande amico, Jack MacGowran – il professor Abronsius di Per favore, non mordermi sul collo! – che racconta di quanto Beckett si ritenesse ‘indegno’ di ricevere un’onorificenza che a James Joyce non venne mai data; quel Joyce col quale ebbe un rapporto molto più importante di quanto tratteggiato da Marsh nel suo film.
Nel saggio introduttivo del Meridiano riflette sulla «lenta inesorabile sparizione dell’opera» dal mercato editoriale italiano, ma non dell’autore, diventato una sorta di icona pop. Come si spiega quest’attenzione schizofrenica nei confronti di Beckett? Pensa ci sia qualcosa nella sua arte che oggi si preferisce rimuovere? Penso a quando scrive «in una società a trazione immaginaria il personaggio divenuto autocosciente è come se ci venisse a stanare».
Sicuramente è così. Quando Beckett apparve sulla scena francese con i suoi primi romanzi – perché è lì che si afferma – è stato immediatamente tradotto in italiano e le case editrici, pur vendendo poco le sue opere, si vantavano di averlo tra i loro autori, consapevoli della sua importanza sulla scena europea. Poi, a partire dagli anni Ottanta, è successo qualcosa che lo ha fatto progressivamente sparire dalle librerie italiane e questo qualcosa – che non ha interessato soltanto l’Italia – è la nascita dei grandi monopoli editoriali che, politicamente, hanno investito su tutto ciò che era semplice. Intendiamoci, è così ovunque, ma nelle altre nazioni la cultura considerata ‘alta’ viene comunque protetta. È triste per un autore che ha amato oltremisura l’Italia; l’autore che forse ha maggiormente letto e ‘usato’ Dante nel Novecento, tanto che una sua amica irlandese in una lettera gli scriveva: «Tu sei il più italiano dei nostri autori».
Un aspetto fondamentale è la natura intermediale dell’opera beckettiana: dalla poesia-narrativa alla drammaturgia, poi la radio (i lavori commissionati dalla Bbc per Third Programme) e, infine, la televisione. Per Beckett però non si è mai trattato di ‘tradurre’ la sua poetica per il diverso formato, ma di ripensare ogni volta il proprio fare a seconda delle specificità del mezzo con cui si andava a confrontare.
Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di committenze. Per la radio è stato così: la Bbc lo ha chiamato per chiedergli esplicitamente un radiodramma e Beckett, invece di spaventarsi, reagì super positivamente. Ma la cosa incredibile è che alla televisione Beckett è arrivato per i fatti suoi: è lui a scrivere un testo per la tv e solo dopo lo manda alla Bbc. Per questo Deleuze ha detto che la televisione lo aspettava come un destino, perché ci è arrivato autonomamente. A un certo punto ha avuto un’idea che non poteva essere per il teatro, ed è stato esattamente quando il suo teatro ha cominciato a utilizzare delle formule che sono tipiche della rappresentazione audiovisiva; basti pensare a Mica io dove sul palcoscenico si vede solo una bocca: quello che in tv sarebbe come un normale primissimo piano a teatro invece ci sconvolge. Beckett ha sentito che la televisione poteva diventare il mezzo della nuova realtà quotidiana e quindi bisognava ripensarsi in relazione a questo strumento, da qui le sue regie – firmate prima di diventare regista teatrale – per la rete televisiva tedesca Sdr. E questo succede in un momento in cui le televisioni dell’epoca, per spinta interna, sono rivolte a sperimentare il mezzo – in Italia succede con Carmelo Bene. Quando Beckett scrive L’ultimo nastro di Krapp coglie nell’utilizzo domestico del nastro magnetico quella tendenza, ora esplosa, di conservare memoria di sé («torna ancora, torna ancora», ripete Krapp), di scannerizzare ogni attimo della nostra vita. Intuisce che quei mezzi che inizialmente ‘subivamo‘ ci avrebbero poi abitato.
Tra i molti mezzi coi quali Beckett si è confrontato c’è anche il cinema, mi riferisco all’esperienza di Film. A riguardo di questo lavoro lei scrive una cosa molto interessante: che Beckett arriva a eludere il montaggio per costringere la macchina a divenire personaggio persecutore.
In quello stesso periodo realizza una messa in scena che si intitola Commedia in cui, grazie all’uso di un riflettore che s’illumina e si spegne inquadrando tre personaggi diversi, crea il montaggio a teatro e poi fa Film, comica tremenda e stralunata (che richiama i versi di una sua poesia: «il peggio/di faccia/finché/ridere faccia») in cui elimina il montaggio e trasforma in incubo l’atto della ripresa (un incubo di cui siamo complici poiché se quella ripresa si compie è perché c’è qualcuno che la guarderà). Oltre a essere un grande appassionato di slapstick comedy – oltre a Chaplin e Keaton, anche di Laurel e Hardy, come si intuisce da Aspettando Godot, perché Estragone e Vladimiro sono chiaramente Stanlio e Ollio – Beckett amava tutto il grande cinema, conosceva benissimo per esempio la scuola sovietica, tanto che nel 1936, non sapendo come condurre l’esistenza, scrive addirittura una lettera a Ejzenštejn per proporsi come aiuto regista. L’unico motivo poi per cui va in America è quello di poter realizzare il suo progetto cinematografico e a infiammarlo, più che la regia di Alan Schneider, è l’idea di lavorare non solo con Keaton ma anche, come direttore della fotografia, con Boris Kaufman, fratello minore di Vertov, che collaborò alla realizzazione di opere per lui fondamentali come Zero in condotta e L’Atalante di Vigo, ma anche di La parola ai giurati di Lumet.
Proprio a riguardo del cinema, ci sono autori che hanno saputo far tesoro della lezione beckettiana?
Sicuramente Losey, attraverso la mediazione di Pinter; Polanski: L’inquilino del terzo piano senza Beckett non si può immaginare. Polanski poi, che avrebbe voluto fare un film su Aspettando Godot ma venne dissuaso dallo stesso autore, ha interpretato nel 2012 il personaggio di Lucky per i sessant’anni della pièce. Poi, i volti di pietra del cinema di Kaurismäki. Ma se vogliamo andare oltre le situazioni, le suggestioni tematiche e le temperature emotive, citerei i Dardenne per l’uso della macchina da presa: la mdp che pedina i personaggi nei primi loro lavori ricorda quella che inseguiva Keaton in Film.